I rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione sono da sempre caratterizzati da una profonda diffidenza. Anche in questo periodo di Covid 19, durante il quale la fiducia verso le istituzioni, in particolare quelle sanitarie, è leggermente aumentata per forza di cose, la logica del sospetto reciproco continua a farla da padrone. Da un lato ci sono i cittadini (non tutti ovviamente) che considerano i funzionari pubblici come una massa di furbi, incapaci, incompetenti, perditempo, raccomandati e corrotti.  Dall’altro ci sono coloro che devono “far girare” la macchina amministrativa a vantaggio della collettività, ma che vedono nei cittadini (non tutti ovviamente) una massa di furbi, incapaci e incompetenti che gli fanno perdere un sacco di tempo, che ricorrono spesso alla raccomandazione del potente di turno e che non disdegnano tentativi di corruzione e concussione. Ad aggravare pesantemente la situazione poi ci sono le tante, troppe, mediocrità politiche che cercano di sfruttare di volta in volta queste difficoltà di rapporti per ricavarne dei momentanei e inconcludenti vantaggi elettorali. Stiamo evidentemente generalizzando, ma è sotto gli occhi di tutti la situazione di stallo (sarebbe meglio parlare di paralisi) del rapporto tra chi ha il dovere-potere di decidere e chi pretende giustamente, pagando le tasse, procedimenti veloci e servizi efficienti. E non parliamo solo di una realtà italiana perché questa situazione di diffidenza persistente si è di nuovo manifestata in occasione della “Brexit” con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea e recentemente tra i gli stessi paesi dell’UE sulla quantificazione e la redistribuzione dei 750 miliardi di euro del “Recovery Fund” per uscire dalla crisi economica aggravata dalla pandemia in corso.
Dall’altro ci sono coloro che devono “far girare” la macchina amministrativa a vantaggio della collettività, ma che vedono nei cittadini (non tutti ovviamente) una massa di furbi, incapaci e incompetenti che gli fanno perdere un sacco di tempo, che ricorrono spesso alla raccomandazione del potente di turno e che non disdegnano tentativi di corruzione e concussione. Ad aggravare pesantemente la situazione poi ci sono le tante, troppe, mediocrità politiche che cercano di sfruttare di volta in volta queste difficoltà di rapporti per ricavarne dei momentanei e inconcludenti vantaggi elettorali. Stiamo evidentemente generalizzando, ma è sotto gli occhi di tutti la situazione di stallo (sarebbe meglio parlare di paralisi) del rapporto tra chi ha il dovere-potere di decidere e chi pretende giustamente, pagando le tasse, procedimenti veloci e servizi efficienti. E non parliamo solo di una realtà italiana perché questa situazione di diffidenza persistente si è di nuovo manifestata in occasione della “Brexit” con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea e recentemente tra i gli stessi paesi dell’UE sulla quantificazione e la redistribuzione dei 750 miliardi di euro del “Recovery Fund” per uscire dalla crisi economica aggravata dalla pandemia in corso.
Il problema principale sta nel fatto che lo Stato, a seguito dei numerosi episodi di malgoverno, di sprechi della spesa pubblica e di scandali politici, non si fida più, sia di se stesso che dei suoi cittadini. Per risolvere questo problema si è pensato solo ad aggiungere ulteriori controlli e verifiche a procedure decisionali già molto farraginose.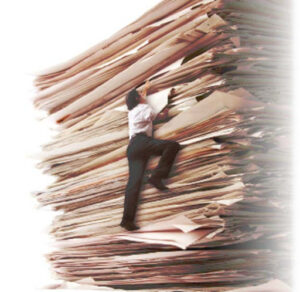 Il risultato è che l’80-90% del lavoro che si svolge dentro gli uffici preposti ad erogare servizi diretti ai cittadini (rifiuti, mense scolastiche, pagamento delle tasse, autorizzazioni e licenze, ecc.) viene dissipato nello scambio di comunicazioni inutili e ripetitive tra gli stessi uffici, mentre lo scambio di informazioni utili, magari una semplice telefonata e seguente invio di posta elettronica certificata, spesso non avviene. L’effetto che si produce, inaccettabile sotto il profilo etico, è quello di assistere a lungaggini burocratiche assurde, soprattutto là dove è necessario intervenire urgentemente: in Italia è ormai questa una “tradizione”, purtroppo, in caso di terremoti e disastri ambientali. E qui parlo per esperienza personale.
Il risultato è che l’80-90% del lavoro che si svolge dentro gli uffici preposti ad erogare servizi diretti ai cittadini (rifiuti, mense scolastiche, pagamento delle tasse, autorizzazioni e licenze, ecc.) viene dissipato nello scambio di comunicazioni inutili e ripetitive tra gli stessi uffici, mentre lo scambio di informazioni utili, magari una semplice telefonata e seguente invio di posta elettronica certificata, spesso non avviene. L’effetto che si produce, inaccettabile sotto il profilo etico, è quello di assistere a lungaggini burocratiche assurde, soprattutto là dove è necessario intervenire urgentemente: in Italia è ormai questa una “tradizione”, purtroppo, in caso di terremoti e disastri ambientali. E qui parlo per esperienza personale.
In Europa da almeno trenta anni esiste una direttiva che impone una procedura comparativa molto veloce, almeno così era nelle intenzioni, che si chiama Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e che implica delle valutazioni amministrative delle conseguenze di un determinato progetto non solo sull’ambiente naturale, ma anche su quello economico e sociale. In Italia questa procedura ormai può raggiungere e superare la durata di dieci anni, al termine del quale ci può essere un esito negativo. Ricorsi e cause giudiziarie seguono a ruota. Questo risultato è quasi sempre determinato da due cause: 1) l’inserimento nella valutazione di richieste di chiarimenti e pareri che nulla hanno a che vedere con il fine dell’intervento; 2) l’istituzione di tavoli tecnici di confronto e/o conferenze dei servizi in successione temporale dove di volta in volta torna in discussione tutto il già valutato e il già deciso.
In Italia questa procedura ormai può raggiungere e superare la durata di dieci anni, al termine del quale ci può essere un esito negativo. Ricorsi e cause giudiziarie seguono a ruota. Questo risultato è quasi sempre determinato da due cause: 1) l’inserimento nella valutazione di richieste di chiarimenti e pareri che nulla hanno a che vedere con il fine dell’intervento; 2) l’istituzione di tavoli tecnici di confronto e/o conferenze dei servizi in successione temporale dove di volta in volta torna in discussione tutto il già valutato e il già deciso.
Esempio: occorre riversare urgentemente un certo quantitativo di sabbia su un tratto di costa sottoposto ad erosione per proteggere degli insediamenti turistici che si trovano all’interno di un parco nazionale. Faticosamente l’Ente interessato (anche se non è proprietario della costa) trova i finanziamenti e se li fa stanziare. Si fa il progetto e si ottengono i pareri favorevoli degli uffici preposti alla valutazione: ufficio regionale difesa costa, agenzia regionale protezione ambientale e parco nazionale. Sembrerebbe che quei pareri siano sufficienti per l’affidamento dei lavori e l’esecuzione dell’intervento da tutti ritenuto urgente. E invece no: un altro ufficio regionale non si fida di quello che fanno gli altri e ritiene la procedura incompleta in quanto non transitata proprio per il proprio ufficio. L’ente interessato risponde che, vista la specificità dei pareri degli altri uffici, quello “mancante” era da ritenersi perfettamente inutile e con un aggravio di costi immotivato. Ma l’altro ufficio regionale decide comunque che la procedura debba arrivare sulle proprie scrivanie e poi si vedrà. Con il risultato finale che quel parere in più, effettivamente non era necessario. Nel frattempo sono passati alcuni mesi e l’intervento urgente non è stato ancora effettuato: lo Stato continua a non fidarsi di se stesso e cosi tutti ne pagano le conseguenze. A peggiorare la situazione interviene infine la mediocrità della politica e della stampa al suo servizio, cercando di sfruttare elettoralmente la situazione, alimentando ulteriormente la sfiducia dei cittadini sconcertati, ma mantenuti rigorosamente nell’ignoranza dei fatti realmente accaduti. Si può immaginare qualcosa di più stupido?
Si fa il progetto e si ottengono i pareri favorevoli degli uffici preposti alla valutazione: ufficio regionale difesa costa, agenzia regionale protezione ambientale e parco nazionale. Sembrerebbe che quei pareri siano sufficienti per l’affidamento dei lavori e l’esecuzione dell’intervento da tutti ritenuto urgente. E invece no: un altro ufficio regionale non si fida di quello che fanno gli altri e ritiene la procedura incompleta in quanto non transitata proprio per il proprio ufficio. L’ente interessato risponde che, vista la specificità dei pareri degli altri uffici, quello “mancante” era da ritenersi perfettamente inutile e con un aggravio di costi immotivato. Ma l’altro ufficio regionale decide comunque che la procedura debba arrivare sulle proprie scrivanie e poi si vedrà. Con il risultato finale che quel parere in più, effettivamente non era necessario. Nel frattempo sono passati alcuni mesi e l’intervento urgente non è stato ancora effettuato: lo Stato continua a non fidarsi di se stesso e cosi tutti ne pagano le conseguenze. A peggiorare la situazione interviene infine la mediocrità della politica e della stampa al suo servizio, cercando di sfruttare elettoralmente la situazione, alimentando ulteriormente la sfiducia dei cittadini sconcertati, ma mantenuti rigorosamente nell’ignoranza dei fatti realmente accaduti. Si può immaginare qualcosa di più stupido?





Comments 1