Togliere la nostra acqua dalle mani dei partiti politici sarà una delle grandi sfide di questo secolo. Qualcuno lo fa già da sempre e i cambiamenti climatici renderanno queste esperienze sempre interessanti come esempi da seguire e da sviluppare nel futuro. A dare “una mano” ci si è messo il fatto che mentre stiamo scrivendo, si sta decidendo di quotare alla Borsa Valori anche l’acqua, come una qualsiasi merce: mais, grano, petrolio o carbone. Anche se ogni essere umano, mediamente, è composto per il 70% proprio di acqua. C’è da restare sgomenti di fronte a tali decisioni che è prima di tutto politica. Vediamo intanto il problema e poi indicheremo una soluzione che è stata messa in atto nei Paesi Bassi, in un territorio che in buona parte già oggi si trova sotto il livello del mare. Partiamo con un esempio.
Voluto da uno schieramento di oltre 400 organizzazioni di volontariato ed appoggiato da alcuni partiti di sinistra, il 12 e 13 giugno di dieci anni fa in Italia si è tenuto un referendum per riportare in mano pubblica la risorsa di cui ogni essere vivente ha bisogno per sopravvivere. In questo paese, come già avvenuto in tante altre parti del mondo, era in corso un processo di privatizzazione strisciante dei servizi idrici e la politica, praticamente di tutti gli schieramenti, stava agevolando questo processo con l’emanazione di alcune leggi che imponevano ai Comuni di non detenere quote di maggioranza nelle società idriche. Con quel referendum i cittadini si espressero chiaramente per la cancellazione di quelle leggi; in particolare la cosiddetta “remunerazione del capitale investito” che sostanzialmente dava ai privati la possibilità di fare affari colossali con la risorsa idrica (dichiarata patrimonio universale dell’umanità dall’ONU) a prescindere dalla qualità del servizio reso alla popolazione. Il ritorno in mano pubblica dell’intera gestione della risorsa idrica a livello nazionale quindi sembrava cosa fatta. Senonché, uno dopo l’altro, tutti i governi che si sono succeduti fino ad oggi, sia di centro-sinistra, sia di centro-destra che “tecnici”, hanno fatto di tutto per ripristinare la situazione precedente al referendum. Le lobby del settore, banche soprattutto, erano tornate all’attacco già subito dopo la votazione e la politica si era prontamente allineata rovesciando, di fatto, la volontà espressa dagli elettori.
In questo paese, come già avvenuto in tante altre parti del mondo, era in corso un processo di privatizzazione strisciante dei servizi idrici e la politica, praticamente di tutti gli schieramenti, stava agevolando questo processo con l’emanazione di alcune leggi che imponevano ai Comuni di non detenere quote di maggioranza nelle società idriche. Con quel referendum i cittadini si espressero chiaramente per la cancellazione di quelle leggi; in particolare la cosiddetta “remunerazione del capitale investito” che sostanzialmente dava ai privati la possibilità di fare affari colossali con la risorsa idrica (dichiarata patrimonio universale dell’umanità dall’ONU) a prescindere dalla qualità del servizio reso alla popolazione. Il ritorno in mano pubblica dell’intera gestione della risorsa idrica a livello nazionale quindi sembrava cosa fatta. Senonché, uno dopo l’altro, tutti i governi che si sono succeduti fino ad oggi, sia di centro-sinistra, sia di centro-destra che “tecnici”, hanno fatto di tutto per ripristinare la situazione precedente al referendum. Le lobby del settore, banche soprattutto, erano tornate all’attacco già subito dopo la votazione e la politica si era prontamente allineata rovesciando, di fatto, la volontà espressa dagli elettori.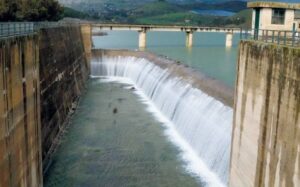 Nella zona dove abita l’autore di questo articolo il servizio è gestito da quasi venti anni da una società pubblico-privata dove il pubblico (con un partito in particolare) si occupa sistematicamente di adeguare al rialzo le bollette in cambio di assunzioni raccomandate presso la società. In questi vent’anni il prezzo pagato dalle utenze è aumentato di oltre il 500%, mentre la qualità del servizio, complessivamente, è peggiorata. Nell’estate di quattro anni fa le proteste della popolazione avevano indotto i Sindaci della zona a riproporre la ri-pubblicizzazione della società, ma poi gli artigli dei partiti sono scattati di nuovo per tener ben salda la preda. Tutto questo sta accadendo mentre secondo un rapporto del 2012 dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), il 40% della popolazione mondiale entro l’anno 2050 vivrà nei bacini fluviali che già oggi sono interessati da una grave carenza di acqua potabile. La risposta che maggior parte di queste aree si apprestano ad adottare è quella di un ulteriore prelievo di acque superficiali e sotterranee. Nel frattempo altre aree del globo avranno a che fare sempre di più con troppa pioggia. E dunque, come si può uscire da una prospettiva cosi catastrofica? Per esempio togliendo di mezzo proprio la politica e il controllo dei partiti sui gestori locali.
Nella zona dove abita l’autore di questo articolo il servizio è gestito da quasi venti anni da una società pubblico-privata dove il pubblico (con un partito in particolare) si occupa sistematicamente di adeguare al rialzo le bollette in cambio di assunzioni raccomandate presso la società. In questi vent’anni il prezzo pagato dalle utenze è aumentato di oltre il 500%, mentre la qualità del servizio, complessivamente, è peggiorata. Nell’estate di quattro anni fa le proteste della popolazione avevano indotto i Sindaci della zona a riproporre la ri-pubblicizzazione della società, ma poi gli artigli dei partiti sono scattati di nuovo per tener ben salda la preda. Tutto questo sta accadendo mentre secondo un rapporto del 2012 dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), il 40% della popolazione mondiale entro l’anno 2050 vivrà nei bacini fluviali che già oggi sono interessati da una grave carenza di acqua potabile. La risposta che maggior parte di queste aree si apprestano ad adottare è quella di un ulteriore prelievo di acque superficiali e sotterranee. Nel frattempo altre aree del globo avranno a che fare sempre di più con troppa pioggia. E dunque, come si può uscire da una prospettiva cosi catastrofica? Per esempio togliendo di mezzo proprio la politica e il controllo dei partiti sui gestori locali.
 I Paesi Bassi (Olanda) si chiamano così perché quella nazione ha più della metà del proprio territorio sotto il livello del mare. Un territorio che storicamente è vulnerabile alle inondazioni e con i cambiamenti climatici in corso non vedrà di certo migliorare la situazione. Allo stesso tempo, essendo quella una delle aree più densamente popolate della Terra, il controllo delle acque è sempre stata considerata una priorità nazionale. Gli olandesi hanno quindi capito per primi che la gestione i tutti i servizi idrici, sia di acqua dolce che salata, doveva restare fuori dal controllo dei governi politici di turno a livello nazionale e regionale, qualunque fosse il loro colore. In tutto il paese la gestione è stata messa nelle mani di esperti e tecnici del settore attraverso le “Waterschappen” (o “water board”): dei veri e propri “governi dell’acqua” su scala regionale. Sono in tutto 21, ma un tempo erano molti di più. Sono sostanzialmente dei “parlamenti idrici” che attraverso i loro consigli di amministrazione agiscono nella più totale indipendenza rispetto alle altre amministrazioni nazionali, regionali e locali.
I Paesi Bassi (Olanda) si chiamano così perché quella nazione ha più della metà del proprio territorio sotto il livello del mare. Un territorio che storicamente è vulnerabile alle inondazioni e con i cambiamenti climatici in corso non vedrà di certo migliorare la situazione. Allo stesso tempo, essendo quella una delle aree più densamente popolate della Terra, il controllo delle acque è sempre stata considerata una priorità nazionale. Gli olandesi hanno quindi capito per primi che la gestione i tutti i servizi idrici, sia di acqua dolce che salata, doveva restare fuori dal controllo dei governi politici di turno a livello nazionale e regionale, qualunque fosse il loro colore. In tutto il paese la gestione è stata messa nelle mani di esperti e tecnici del settore attraverso le “Waterschappen” (o “water board”): dei veri e propri “governi dell’acqua” su scala regionale. Sono in tutto 21, ma un tempo erano molti di più. Sono sostanzialmente dei “parlamenti idrici” che attraverso i loro consigli di amministrazione agiscono nella più totale indipendenza rispetto alle altre amministrazioni nazionali, regionali e locali.  Vengono eletti ogni quattro anni nello stesso giorno in cui si tengono le elezioni provinciali ed hanno autonomia anche nell’imporre le tasse in base a criteri di conservazione e mantenimento della risorsa: ad esempio, i costi per il trattamento delle acque reflue sono finanziati da una tassa specifica sull’inquinamento idrico basata sul principio di “chi inquina paga”. A fare la differenza rispetto al sistema dei partiti, è sia la modalità di elezione che di quella selezione. Ogni elettore viene informato prima delle votazioni dei nomi che compongono una lista elettorale e dove si trovano i seggi elettorali locali. I collegi elettorali però non corrispondono alle varie circoscrizioni territoriali ma alle varie categorie di portatori di interesse (stakeholder): proprietari terrieri, locatari, proprietari di edifici, aziende e tutti i residenti. Quella delle “Waterschappen” nei Paesi Bassi è tra le più antiche forme di governo locale dei beni comuni (alcune sono state fondate nel XIII° secolo) ed hanno contribuito a formare e forgiare le altre istituzioni democratiche di quel paese. Sono nate da un fortissimo spirito cooperativistico della popolazione locale per difendere la terra prosciugata per l’agricoltura, quando ha iniziato a difenderla dalle inondazioni: sia da terra che da mare. Per questo motivo gli elettori eleggono sostanzialmente chi gli pare e non per indirizzo partitico. L’organo amministrativo generale poi elegge alcuni dei suoi membri nel consiglio di amministrazione, che è rappresentano tradizionalmente da cinque tipi di utenti dell’acqua: la popolazione locale (residenti), l’industria (fabbriche ed edifici industriali), i Comuni (aree urbane ), gli agricoltori (terreni agricoli) e i gestori di parchi pubblici. Il presindente del consiglio di amministrazione, ha gli stessi poteri di un Sindaco a livello locale e di commissario del Re nel governo provinciale. Tra le esigenze prioritarie di gestione sono anche il controllo della qualità dell’acqua e la salute degli ecosistemi acquatici.
Vengono eletti ogni quattro anni nello stesso giorno in cui si tengono le elezioni provinciali ed hanno autonomia anche nell’imporre le tasse in base a criteri di conservazione e mantenimento della risorsa: ad esempio, i costi per il trattamento delle acque reflue sono finanziati da una tassa specifica sull’inquinamento idrico basata sul principio di “chi inquina paga”. A fare la differenza rispetto al sistema dei partiti, è sia la modalità di elezione che di quella selezione. Ogni elettore viene informato prima delle votazioni dei nomi che compongono una lista elettorale e dove si trovano i seggi elettorali locali. I collegi elettorali però non corrispondono alle varie circoscrizioni territoriali ma alle varie categorie di portatori di interesse (stakeholder): proprietari terrieri, locatari, proprietari di edifici, aziende e tutti i residenti. Quella delle “Waterschappen” nei Paesi Bassi è tra le più antiche forme di governo locale dei beni comuni (alcune sono state fondate nel XIII° secolo) ed hanno contribuito a formare e forgiare le altre istituzioni democratiche di quel paese. Sono nate da un fortissimo spirito cooperativistico della popolazione locale per difendere la terra prosciugata per l’agricoltura, quando ha iniziato a difenderla dalle inondazioni: sia da terra che da mare. Per questo motivo gli elettori eleggono sostanzialmente chi gli pare e non per indirizzo partitico. L’organo amministrativo generale poi elegge alcuni dei suoi membri nel consiglio di amministrazione, che è rappresentano tradizionalmente da cinque tipi di utenti dell’acqua: la popolazione locale (residenti), l’industria (fabbriche ed edifici industriali), i Comuni (aree urbane ), gli agricoltori (terreni agricoli) e i gestori di parchi pubblici. Il presindente del consiglio di amministrazione, ha gli stessi poteri di un Sindaco a livello locale e di commissario del Re nel governo provinciale. Tra le esigenze prioritarie di gestione sono anche il controllo della qualità dell’acqua e la salute degli ecosistemi acquatici. L’operato dell’organo amministrativo viene poi supervisionato dal governo superiore (la provincia) per assicurare che i mandati siano rispettati, che gli aumenti salariali siano equi e che i costi dei progetti siano ragionevoli. Una volta che i loro bilanci sono approvati, l’utenza viene tassata in base alla proprietà e all’utilizzazione che ne fa ciascuno, considerando che la gestione dell’acqua aiuta a proteggere la terra e le proprietà e chi possiede di più dovrebbe pagare di più.
L’operato dell’organo amministrativo viene poi supervisionato dal governo superiore (la provincia) per assicurare che i mandati siano rispettati, che gli aumenti salariali siano equi e che i costi dei progetti siano ragionevoli. Una volta che i loro bilanci sono approvati, l’utenza viene tassata in base alla proprietà e all’utilizzazione che ne fa ciascuno, considerando che la gestione dell’acqua aiuta a proteggere la terra e le proprietà e chi possiede di più dovrebbe pagare di più.
Il risultato è la conferma di un’impostazione storica dell’accordo tra uomo e Natura. Lasciando fuori dalla gestione dell’acqua il governo centrale e i governi regionali, gli olandesi proteggono la loro acqua anche dalle ingerenze della politica partitica. Il servizio idrico non deve stare a combattere con le ristrettezze che interessano tutti gli altri servizi pubblici essenziali, con i relativi interessi elettorali: sanità, istruzione, trasporti e, persino, le spese militari. Questo modello si è rivelato così efficente che è stato considerato come un “esempio di riferimento” proprio dall’OCSE che lo sta sta consigliando ai governi di tutto il mondo. Compresi quelli che , alle condizioni attuali di uso della risorsa, rischiano di trovarsi dentro la catastrofe della carenza di acqua nel 2050.




Comments 2