La carne di pipistrello è considerata molto prelibata nei pesi dell’est asiatico perché avrebbe un sapore simile al pollo. Noi non l’abbiamo mai mangiata e ce ne guardiamo bene dal farlo, non per ragioni alimentari o sanitarie, ma per le semplici ragioni illustate in questo articolo: I nostri amici pipistrelli. Il  fatto che l’attuale pandemia da coronavirus sarebbe partita da un mercato cinese a causa dell’abitudine della popolazione locale di consumare questo tipo di carne, cosa che è ancora da dimostrare, ha portato alla luce la necessità di avere, a livello globale, un rapporto completamente diverso con i processi naturali. Anziché contrastarla, ‘soggiogarla’ o modificarla, se la imitiamo, la Natura è una eccellente alleata. Creature, ecosistemi e realtà naturali già esistenti sul pianeta forniscono sempre più ottime soluzioni innovative ed ecosostenibli nei vari settori, dall’agricoltura all’industria, dall’energia al cibo, dai trasporti alla moda e così via. Ed è proprio dalla diversità nelle abitudini alimentari che questa tendenza (che definiamo “Natureconomy”: Nature economy, business che valorizzano la natura) si sta rivelando sempre di più l’occasione propizia per rifondare l’intera economia mondiale. Ecco perché.
fatto che l’attuale pandemia da coronavirus sarebbe partita da un mercato cinese a causa dell’abitudine della popolazione locale di consumare questo tipo di carne, cosa che è ancora da dimostrare, ha portato alla luce la necessità di avere, a livello globale, un rapporto completamente diverso con i processi naturali. Anziché contrastarla, ‘soggiogarla’ o modificarla, se la imitiamo, la Natura è una eccellente alleata. Creature, ecosistemi e realtà naturali già esistenti sul pianeta forniscono sempre più ottime soluzioni innovative ed ecosostenibli nei vari settori, dall’agricoltura all’industria, dall’energia al cibo, dai trasporti alla moda e così via. Ed è proprio dalla diversità nelle abitudini alimentari che questa tendenza (che definiamo “Natureconomy”: Nature economy, business che valorizzano la natura) si sta rivelando sempre di più l’occasione propizia per rifondare l’intera economia mondiale. Ecco perché.
Nella cultura alimentare occidentale a nessuno verrebbe mai in mente se per pranzo o cena è meglio cucinare un bella bistecca di manzo o qualche etto di cavallette al forno. A Bangkok invece, capitale della Thailandia, dove la carne non è alla portata della popolazione più povera, la questione si pone al contrario perché questi insetti sono considerati un ottimo alimento, completo dal punto di vista dei nutrienti, igienicamente sicuro e persino salutare. Le cavallette, infatti, rispetto alla carne di mucca hanno un più alto contenuto di proteine (72% contro il 52%), hanno molti grassi in meno (16% contro il 48%) ed apportano alla dieta di chi le mangia anche una discreta quantità di carboidrati (12%).
A Bangkok invece, capitale della Thailandia, dove la carne non è alla portata della popolazione più povera, la questione si pone al contrario perché questi insetti sono considerati un ottimo alimento, completo dal punto di vista dei nutrienti, igienicamente sicuro e persino salutare. Le cavallette, infatti, rispetto alla carne di mucca hanno un più alto contenuto di proteine (72% contro il 52%), hanno molti grassi in meno (16% contro il 48%) ed apportano alla dieta di chi le mangia anche una discreta quantità di carboidrati (12%).
L’attività di catturare insetti commestibili quindi, da quelle parti assicura una costante fonte di reddito, soprattutto alle famiglie più bisognose. A questa esigenza ha pensato un gruppo di giovani studenti thailandesi che ha messo a punto un tipo di vasi a forma di ampolla fatti con fibre naturali. Si tratta di vere e proprie trappole che sulla parte esterna sono decorate con colori che attraggono gli insetti: possono essere appese in qualsiasi posto.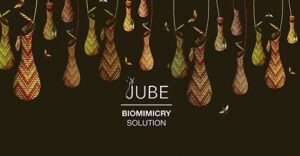 Una volta entrati o caduti al loro interno, dei piccoli filamenti pieghevoli fanno cadere questi insetti verso la parte bassa dei vasi senza che questi possano poi risalire. Al di là delle sensazioni sgradevoli che ci possa suscitare il tutto, questo è proprio il meccanismo con il quale si alimentano molte piante carnivore. Per mettere a punto queste trappole, infatti, gli studenti thailandesi si sono ispirati ad una di queste piante, la Genlisea violacea, originaria del Brasile. Di progetti del genere ormai se ne stanno sviluppando talmente tanti che ci sono concorsi internazionali nati appositamente per premiare i migliori.
Una volta entrati o caduti al loro interno, dei piccoli filamenti pieghevoli fanno cadere questi insetti verso la parte bassa dei vasi senza che questi possano poi risalire. Al di là delle sensazioni sgradevoli che ci possa suscitare il tutto, questo è proprio il meccanismo con il quale si alimentano molte piante carnivore. Per mettere a punto queste trappole, infatti, gli studenti thailandesi si sono ispirati ad una di queste piante, la Genlisea violacea, originaria del Brasile. Di progetti del genere ormai se ne stanno sviluppando talmente tanti che ci sono concorsi internazionali nati appositamente per premiare i migliori.
Il primo (che ormai è anche il più prestigioso) è quello organizzato del Biomimicry Institute (Istituto per la Biomimetica), per progetti ispirati alla Natura, che non è nato dalla stravaganza di qualche filantropo ambientalista, ma da un preciso orientamento economico che stiamo qui illustrando. Basti pensare che un rapporto redatto alcuni anni fa dall’Istituto per gli Affari Economici della Fermanian University di Point Loma (San Diego, California) afferma che entro il 2030 le innovazioni ispirate ai cicli naturali potrebbero generare in incremento del PIL a livello mondiale di 1,6 trilioni di dollari americani all’anno (quasi 1.500 miliardi di euro al cambio attuale). 
Jube, il progetto illustrato in questa pagina, è solo uno dei tanti che hanno partecipato ad un concorso internazionale indetto recentemente proprio dal Biomimicry Institute, che si trova nello stato americano del Montana, per premiare sistemi e tecniche di produzione alimentare che emulano la natura. Ogni anno la sfida tra i partecipanti, formati soprattutto da gruppi di studenti e ricercatori universitari e indipendenti, consiste nel proporre in chiave ecocompatibile diverse soluzioni ai gravi problemi che stanno interessando l’agricoltura a livello mondiale. Tali soluzioni però sono obbligate dalle regole del concorso ad avere altri due vincoli fondamentali: devono contemplare una loro trasposizione in chiave industriale e devono copiare-imitare disegni stilistici o fenomeni naturali.
Al concorso annuale del Biomimicry Institute vengono ammessi progetti provenienti da tutto il mondo. Nell’anno di riferimento, il progetto thailandese per la cattura delle cavallette alimentari che abbiamo preso ad esempio è arrivato terzo. Primi a pari merito sono arrivati un progetto canadese ed uno americano.
Quello canadese, chiamato “WindChill Food Preservation Unit”, che significa unità di conservazione del cibo con raffreddamento a vento, è stato messo a punto da un gruppo di ricercatori dell’Università di Calgary e promette di cambiare il destino di tutte quelle persone che vivono nelle zone del pianeta tutt’oggi sprovviste di energia elettrica. È sostanzialmente un piccolo frigorifero che permette di mantenere il cibo a basse temperature anche quando viene trasportato. Il meccanismo di raffreddamento è ispirato alla regolazione della temperatura che operano molti mammiferi e insetti (canguri, elefanti, suricati, api e termiti), attraverso la ventilazione costante del proprio corpo: grosso modo quello che fa il compressore nei nostri frigoriferi domestici, asportando il calore da un lato e immettendo il gas refrigerante dall’altro.
È sostanzialmente un piccolo frigorifero che permette di mantenere il cibo a basse temperature anche quando viene trasportato. Il meccanismo di raffreddamento è ispirato alla regolazione della temperatura che operano molti mammiferi e insetti (canguri, elefanti, suricati, api e termiti), attraverso la ventilazione costante del proprio corpo: grosso modo quello che fa il compressore nei nostri frigoriferi domestici, asportando il calore da un lato e immettendo il gas refrigerante dall’altro.
Illustrare tutti i fantasiosi progetti presentati ogni anno al concorso del Biomimicry Institute è praticamente impossibile, ma meritano attenzione due in particolare perché affrontano un problema molto importante. Si chiama “The Mangrove Still” e lo ha elaborato un gruppo di ricercatori indipendenti di Brescia (Italia). I temi sono quelli del degrado del suolo e della scarsità d’acqua: due sfide globali che se non risolte potrebbero compromettere in futuro la sicurezza alimentare a livello mondiale, ma che già oggi colpiscono il sostentamento soprattutto delle popolazioni povere, il cui reddito dipende fortemente dall’agricoltura. In questo caso l’ispirazione è stata fornita dagli ecosistemi costieri caratterizzati dalla presenza delle mangrovie: alberi in grado di vivere e di gestire le risorse idriche in un ambiente caratterizzato da acqua salata, trasformandolo in acqua dolce.
In questo caso l’ispirazione è stata fornita dagli ecosistemi costieri caratterizzati dalla presenza delle mangrovie: alberi in grado di vivere e di gestire le risorse idriche in un ambiente caratterizzato da acqua salata, trasformandolo in acqua dolce.
Con un sistema modulare, le fibre delle mangrovie possono essere assemblate per irrigare la terra e dare acqua potabile alle persone. Inoltre, questo progetto ispirato alla Natura potrebbe essere utilizzato anche per il trattamento di acqua inquinata o come un essiccatore per processi di produzione alimentare.
E addirittura come dissalatore per trasformare l’acqua marina in acqua potabile o per irrigazione. Il sistema ha un’efficienza paragonabile agli attuali distillatori solari, ma costa almeno 5 volte di meno: per questo risulta finanziariamente sostenibile anche per i Paesi poveri. A maggior ragione perché il processo consente la progressiva rigenerazione di vegetazione sia nei terreni costieri, soggetti all’erosione delle coste, che nei terreni aridi limitrofi al mare.
L’altro progetto considerato si chiama “The Living Filtration System” ed è stato elaborato dai ricercatori dell’Università americana di Eugene, nell’Oregon. Promette di risolvere un altro grave problema: l’inquinamento delle falde acquifere causato dall’uso di fertilizzanti e pesticidi, il quale a sua volta determina un eccesso di nutrienti nei laghi, nei fiumi e nel mare, causandone l’eutrofizzazione, ossia l’abnorme ed eccessivo accrescimento di piante acquatiche.
Promette di risolvere un altro grave problema: l’inquinamento delle falde acquifere causato dall’uso di fertilizzanti e pesticidi, il quale a sua volta determina un eccesso di nutrienti nei laghi, nei fiumi e nel mare, causandone l’eutrofizzazione, ossia l’abnorme ed eccessivo accrescimento di piante acquatiche.
È un sistema di filtraggio, che consiste in una sorta di tubo continuo, che viene interrato sotto la superficie dei terreni coltivati, e funziona come un filtro che permette l’allontanamento dell’acqua in eccesso, ma allo stesso tempo lascia i nutrienti sul terreno a disposizione delle radici delle piante. Una membrana poi permette il passaggio dell’acqua filtrata, ma non quello dei pesticidi e dei residui di fertilizzanti chimici, che in tal modo vengono intrappolati per poi essere metabolizzati dai microrganismi presenti nel terreno. Questo filtro non necessita di alcuna manutenzione dopo l’installazione, perché è composto da materiali naturali. L’intero meccanismo, infatti, trae ispirazione da come funzionano i villi nello stomaco dei lombrichi: i fertilizzatori naturali per eccellenza dei terreni agricoli. Simili sistemi potrebbero aiutare moltissimo ad arginare l’inquinamento delle falde idriche, anche in vaste zone agricole in tutto il mondo. Rifondare l’economia con i processi ecologici e naturali quindi, non solo è auspicabile, ma ormai è sempre di più una realtà concreta.




