I Sindaci e le amministrazioni locali hanno un potenziale enorme per raggiungere subito gli obiettivi dell’economia circolare. Con questo articolo iniziamo a fornire alcuni esempi pratici e operativi, perché le cose a livello nazionale, europeo e globale stanno andando molto peggio del previsto: occorre dirlo con franchezza. In base al “Rapporto sul Divario della Circolarità dell’Economia” per il 2021, pubblicato recentemente a cura dell’organizzazione mondiale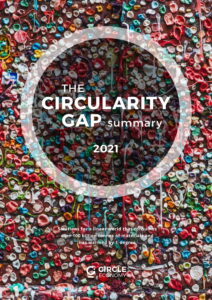 (Piattaforma per l’Accelerazione dell’Economia Circolare- formata da eminenti studiosi di fama internazionale) nessun paese al mondo oggi è fermamente sulla strada del raggiungimento degli obiettivi siglati a Parigi nel 2015, per fare di questo pianeta un luogo socialmente giusto ed ecologicamente sicuro. Anzi, all’atto pratico, c’è persino una regressione in corso che solo in minima parte è giustificata dalla pandemia da coronavirus. Il Rapporto rivela che nel 2020 l’economia globale era circolare all’8,6%, mentre nel 2018 questa percentuale era al 9,1: in appena 2 anni si è perso lo 0,5% di circolarità economica. Nel frattempo, sempre su scala mondiale, è stato sfondato il tetto dei cento miliardi di tonnellate di materie prime consumate (quasi tutte destinate a diventare rifiuti) ed è ormai accertato che il clima è già diventato più caldo di 1 grado Celsius. In sostanza il pianeta resta ancora incatenato all’obsolescenza e alla stupida logica dell’economia lineare.
(Piattaforma per l’Accelerazione dell’Economia Circolare- formata da eminenti studiosi di fama internazionale) nessun paese al mondo oggi è fermamente sulla strada del raggiungimento degli obiettivi siglati a Parigi nel 2015, per fare di questo pianeta un luogo socialmente giusto ed ecologicamente sicuro. Anzi, all’atto pratico, c’è persino una regressione in corso che solo in minima parte è giustificata dalla pandemia da coronavirus. Il Rapporto rivela che nel 2020 l’economia globale era circolare all’8,6%, mentre nel 2018 questa percentuale era al 9,1: in appena 2 anni si è perso lo 0,5% di circolarità economica. Nel frattempo, sempre su scala mondiale, è stato sfondato il tetto dei cento miliardi di tonnellate di materie prime consumate (quasi tutte destinate a diventare rifiuti) ed è ormai accertato che il clima è già diventato più caldo di 1 grado Celsius. In sostanza il pianeta resta ancora incatenato all’obsolescenza e alla stupida logica dell’economia lineare.
Come in ogni legge del contrappasso (se succede qualcosa di negativo, di solito poi succede qualcosa di senso opposto), per fortuna stanno aumentando di giorno in giorno gli esempi di realtà locali che invece la strada dell’economia circolare, non solo l’hanno imboccata con decisione, ma stanno ottenendo anche risultati inimmaginabili fino a poco tempo fa. In particolare per quanto riguarda la creazione di nuovi posti di lavoro e la realizzazione di condizioni strutturali per uno sviluppo duraturo, equo, solidale e sostenibile. Con l’economia circolare nel prossimo futuro saranno necessarie nuove figure professionali , una sorta di moderni artigiani, che nella gestione dei beni comuni troveranno il loro laboratorio di apprendistato. D’altra parte i Comuni sono grandi proprietari di immobili (sedi municipali, scuole, impianti sportivi, ecc.) e di infrastrutture già esistenti (strade, acquedotti, linee elettriche e telefoniche, ecc.) sui quali, ad esempio, si possono creare centrali di rete con pannelli fotovoltaici e wi-fi libero per l’accesso gratuito ad Internet. I Comuni poi sono grandi proprietari di biblioteche, spesso chiuse e ammuffite: pochi utenti le frequentano perché c’è scarso interesse generale nella cultura storica e moderna (e Dio solo sa quanto ci sarebbe bisogno di recuperare questo interesse). Queste biblioteche potrebbero essere organizzate come una libreria o un supermercato che attirano interesse invece di stare ferme ad “attendere gli utenti”: un luogo cioè, dove si entra per cercare un libro e un desplay ci indica come trovarlo. I Comuni sono anche proprietari dei centri raccolta dei rifiuti destinati al trattamento e allo smaltimento: con semplici accorgimenti questi centri possono essere trasformati in luoghi di scambio e rigenerazione dei prodotti ancora riutilizzabili. Anche se il discorso è leggermente più complesso, tra i progetti impostati in modo circolare gestibili dagli enti comunali potrebbero rientrare anche i siti industriali dismessi,
, una sorta di moderni artigiani, che nella gestione dei beni comuni troveranno il loro laboratorio di apprendistato. D’altra parte i Comuni sono grandi proprietari di immobili (sedi municipali, scuole, impianti sportivi, ecc.) e di infrastrutture già esistenti (strade, acquedotti, linee elettriche e telefoniche, ecc.) sui quali, ad esempio, si possono creare centrali di rete con pannelli fotovoltaici e wi-fi libero per l’accesso gratuito ad Internet. I Comuni poi sono grandi proprietari di biblioteche, spesso chiuse e ammuffite: pochi utenti le frequentano perché c’è scarso interesse generale nella cultura storica e moderna (e Dio solo sa quanto ci sarebbe bisogno di recuperare questo interesse). Queste biblioteche potrebbero essere organizzate come una libreria o un supermercato che attirano interesse invece di stare ferme ad “attendere gli utenti”: un luogo cioè, dove si entra per cercare un libro e un desplay ci indica come trovarlo. I Comuni sono anche proprietari dei centri raccolta dei rifiuti destinati al trattamento e allo smaltimento: con semplici accorgimenti questi centri possono essere trasformati in luoghi di scambio e rigenerazione dei prodotti ancora riutilizzabili. Anche se il discorso è leggermente più complesso, tra i progetti impostati in modo circolare gestibili dagli enti comunali potrebbero rientrare anche i siti industriali dismessi, i luoghi degradati sotto il profilo sociale e ambientale (persino le ex discariche) e altri luoghi identitari della comunità (dimore e giardini storici abbandonati o caduti in disuso). I beni comuni in sostanza, cioè qualsiasi risorsa condivisa, che è in comproprietà o co-governata da una comunità di utenti e dalle parti interessate, tramite imput dei Sindaci e delle amministrazioni locali possono diventare un fattore di valorizzazione economica di ciò che oggi invece è solo un costo.
i luoghi degradati sotto il profilo sociale e ambientale (persino le ex discariche) e altri luoghi identitari della comunità (dimore e giardini storici abbandonati o caduti in disuso). I beni comuni in sostanza, cioè qualsiasi risorsa condivisa, che è in comproprietà o co-governata da una comunità di utenti e dalle parti interessate, tramite imput dei Sindaci e delle amministrazioni locali possono diventare un fattore di valorizzazione economica di ciò che oggi invece è solo un costo.
Prendiamo come primo esempio la città fiamminga di Gand, in Belgio. Con una popolazione di circa 250mila abitanti, negli ultimi 10 anni questo Comune è diventato rapidamente il centro dei più innovativi progetti di beni comuni urbani oggi esistenti al mondo. L’amministrazione, d’intesa con i cittadini, ne ha avviati oltre 500 (non tutti ben riusciti per la verità), promuovendo l’autogoverno da parte degli stessi cittadini/utenti. Il progetto che ha destato fin dall’inizio una forte adesione è stato la creazione della sede locale della cooperativa per le energie rinnovabili “REScoop” (attiva ormai in molti stati europei). Con una modesta somma, ogni residente può diventare membro di questa cooperativa di energia pulita, divenendone comproprietario e co-gestore dell’impresa. Questo modello da un lato è più conveniente proprio per i residenti a basso reddito, mentre dall’altro tutti i membri possono condividere l’efficienza dei pannelli solari nel loro complesso: come se fosse un’unica centrale di produzione. Quando i tetti di molti membri della cooperativa, per ovvie ragioni ubicative, non risultano posizionati in modo ottimale per ricevere abbastanza luce solare nelle varie stagioni dell’anno, le stesse utenze possono accedere e condividere l’energia disponibile, indipendentemente dal fatto che la propria casa raccolga o meno la stessa quantità di energia solare di altre località. Di fatto è una forma altamente democratica per per produrre e gestire l’energia.
Quando i tetti di molti membri della cooperativa, per ovvie ragioni ubicative, non risultano posizionati in modo ottimale per ricevere abbastanza luce solare nelle varie stagioni dell’anno, le stesse utenze possono accedere e condividere l’energia disponibile, indipendentemente dal fatto che la propria casa raccolga o meno la stessa quantità di energia solare di altre località. Di fatto è una forma altamente democratica per per produrre e gestire l’energia.
Questi tipi di progetti di cooperative energetiche auto sufficienti e solidali, che ormai si stanno diffondendo rapidamente in tutto il mondo, di solito vengono avviate su base spontanea dai cittadini e sono agevolate dalle amministrazioni locali. La cosa molto interessante, visto l’immobilismo dei governi centrali che abbiamo indicato all’inizio di questo approfondimento, è che l’iniziativa potrebbe essere presa direttamente dai Sindaci: cioè che siano le amministrazioni comunali a dare l’imput iniziale, mettendo a disposizione uno dei sui immobili (una scuola ad esempio) per iniziare a formare sia la cooperativa energetica a vantaggio delle fasce sociali più deboli che le relative competenze (nuovi artigiani). In fondo al giorno d’oggi bastano appena 25 metri quadrati di pannelli fotovoltaici per il fabbisogno energetico di una famiglia (3 kilowattora). Il costo di istallazione è la spesa che in molti non possono ancora permettersi ed invece con l’energia rinnovabile di comunità, anche il costo finanziario diventa più sopportabile per le fasce più deboli della comunità. La collaborazione tra cittadini, aziende e Comuni che si impegnano a generare, trasportare e utilizzare energia sostenibile nella gestione collettiva ormai sta diventando un vero e proprio “boom” economico. Esistono forme di gestione simili anche in Danimarca, dove più di 100.000 cittadini sono affiliati a più di 2.000 cooperative di energia eolica. Il fenomeno include anche Stati Uniti, Regno Unito, Svezia, Australia e Germania. Le associazioni sono solitamente collegate a villaggi, distretti, città o altre unità geografiche relativamente piccole, ma ormai stanno diventando operative anche a livello nazionale proponendo un mix di fonti rinnovabili: fotovoltaiche, eoliche, biometano, geotermico. Ogni volta si sceglie la fonte più adatta anche sotto i profili economici e occupazionali. Il tutto senza sussidi statali, con una forte coesione sociale e con l’affrancazione della fornitura dai grandi colossi energetici: il bene comune in tutti i sensi …
La collaborazione tra cittadini, aziende e Comuni che si impegnano a generare, trasportare e utilizzare energia sostenibile nella gestione collettiva ormai sta diventando un vero e proprio “boom” economico. Esistono forme di gestione simili anche in Danimarca, dove più di 100.000 cittadini sono affiliati a più di 2.000 cooperative di energia eolica. Il fenomeno include anche Stati Uniti, Regno Unito, Svezia, Australia e Germania. Le associazioni sono solitamente collegate a villaggi, distretti, città o altre unità geografiche relativamente piccole, ma ormai stanno diventando operative anche a livello nazionale proponendo un mix di fonti rinnovabili: fotovoltaiche, eoliche, biometano, geotermico. Ogni volta si sceglie la fonte più adatta anche sotto i profili economici e occupazionali. Il tutto senza sussidi statali, con una forte coesione sociale e con l’affrancazione della fornitura dai grandi colossi energetici: il bene comune in tutti i sensi …




